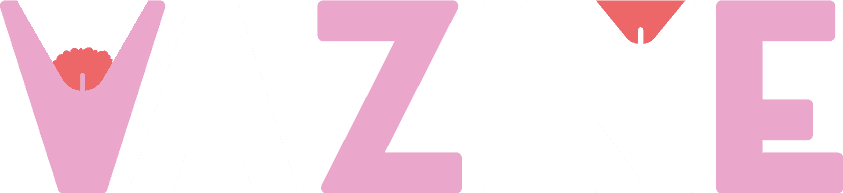Gruppo di Lettura
Il Gruppo di Lettura!
Il Collettivo Vazine e la Biblioteca Archivio Piero Calamandrei vi aspettano per il primo appuntamento del Gruppo di lettura “Il transfemmismo e la letteratura”. Una bellissima occasione per un confronto e discussione sui temi del femminismo, transfemmismo e le questioni di genere.

Settimo Appuntamento
18 Aprile 2024 dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo sarà: LE TRE GHINEE di Virginia Woolf

In “Le tre ghinee”, scritto nell’inverno 1937-1938 mentre la guerra stava per diventare una dolorosa realtà, Virginia Woolf immagina di ricevere tre lettere che contengono una richiesta in denaro per tre cause: la prevenzione della guerra, una università femminile e un’assistenza alle donne che vogliono esercitare una professione. Nelle immaginarie risposte l’autrice dimostra come le tre cause siano identiche e inseparabili; come alla radice di tutto ci sia il potere garantito dalla violenza, uno stesso meccanismo che produce il patriarcato e il fascismo, che fa l’uomo protagonista di un contesto sociale e isola la donna nella sfera privata, alienando entrambi.
Nell’aprile del 1938, alla fine di questo lavoro, Virginia Woolf scrisse nel suo diario: “Hitler dunque sta accarezzando i suoi spinosi baffetti. L’intero mondo trema: e il mio libro sarà forse come una farfalla sopra un falò consumato in meno di un secondo”. Introduzione di Luisa Muraro.
Sesto Appuntamento
13 Marzo 2024 dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo sarà: I RACCONTI DEL SESSO E DELLA MENZOGNA di Leila Slimani

Benvenuti nella «società della menzogna». Una società che santifica la verginità pur essendo la quinta al mondo per consumo di pornografia online.
Tredici racconti sulla sessualità in Marocco: tredici testimonianze spontanee raccolte dalla scrittrice Leïla Slimani. Sono voci di donne di estrazione sociale differente, con un livello di istruzione e un sentimento religioso profondamente diversi, eppure parlano tutte la stessa lingua e muovono un atto di accusa senza riserve verso una società in netta contraddizione tra quanto predica e quanto vive. La studentessa, la prostituta, il medico, l’attivista, il poliziotto ci offrono uno spaccato spietato della vita sessuale in Marocco, fatta di incontri rubati, consumati nei cantieri abbandonati, con la paura di essere scoperti dalla polizia o aggrediti da qualcuno. Il sesso fuori dal matrimonio è proibito per legge, il codice penale sanziona il crimine con due anni di carcere. Non si può abortire, a meno di non essere state violentate. Succede anche che le donne vittime di stupro possano essere sposate dai loro stessi violentatori. Questo è quello che prescrive la legge marocchina oggi, una giurisprudenza scollata dalle esigenze di una comunità per molti versi modernizzata, in cui le donne reclamano il tempo di conoscere e desiderare gli uomini con cui escono e rivendicano la libertà di rifiutarli. Se le ragazze non parlano di sesso in famiglia, né confidano alle amiche le loro relazioni non ufficiali, dall’altra i giovani uomini non sposano donne che abbiano perso la verginità.
Che tipo di società è questa? Leïla Slimani, scrittrice Premio Goncourt all’apice del successo e acuta osservatrice dell’identità femminile nelle sue infinite declinazioni, lascia alle parole di queste donne la risposta.
Quinto Appuntamento
24 Gennaio 2024 dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo sarà: AFFAMATA di Melissa Broder

Rachel ha venticinque anni, vive a Los Angeles e soffre di un disturbo alimentare: calcola ossessivamente le calorie, cerca di ignorare la fame e trae un piacere quasi erotico dai pochi cibi che si concede. Lavora per un noto agente dello spettacolo, ogni giovedì sera si esibisce come stand-up comedian e si nasconde dalla madre, anaffettiva e dominante. Rachel usa la solitudine come scudo contro le relazioni e le tentazioni, finché un giorno, nella gelateria dove consuma di nascosto uno yogurt ipocalorico, incontra Miriam, la nuova commessa. Miriam è l’opposto di Rachel: un tripudio di curve e morbidezze, il trionfo dell’abbondanza sulla privazione. Le due ragazze si innamorano, si esplorano attraverso il cibo che consumano insieme, si riconoscono nei corpi che traboccano di piacere. L’amore innesca una rivoluzione nella vita di Rachel, che però dovrà fare i conti con la famiglia ebrea ortodossa di Miriam e con le ipocrisie del suo ambiente di lavoro. Serrato, impetuoso e provocatorio, Affamata parla di sensi e appetiti: di sesso, di cibo e di ossessioni. Con una lingua ironica e sensuale, Melissa Broder rivela che per sfuggire all’infelicità l’unica strada è tornare a se stesse, affrontando il rischio di non essere conformi e la vertigine del desiderio. Questo libro è per chi sa che i biscotti della fortuna non mentono mai, per chi sogna di chiedere a Midge Maisel la ricetta del suo brisket, per chi vorrebbe scoprire quali sono gli m&m’s preferiti da dio, e per chi ha capito che nella vita non bisogna per forza andare avanti, ma ci si può muovere liberamente, verso l’alto e poi giù in profondità, in una serie di infiniti crescendo.
Melissa Broder è un’autrice americana di romanzi, racconti, saggi e poesie, selezionate dal Center For Fiction First Novel Prize e dal Women’s Prize For Fiction. Collabora con The New York Times, Elle e The Cut. Vive a Los Angeles.
Quarto Appuntamento
14 Dicembre dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo sarà: La figlia unica di Guadalupe Nettel

Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent’anni. Ora sono tornate in Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando un’ecografia rivela che la bambina ha una malformazione e probabilmente non sopravvivrà al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso processo di accettazione. Non sanno ancora che quella bambina riserva loro delle sorprese. È Laura a narrarci i dilemmi della coppia, mentre anche lei riflette sulle incomprensibili logiche dell’amore e sulle strategie che inventiamo per superare le delusioni. E infine c’è Doris, vicina di casa di Laura, madre sola di un figlio adorabile ma impossibile da gestire.
Scritto con una semplicità solo apparente, La figlia unica è la storia di tre donne e dei legami d’amore e d’amicizia che intessono mentre si confrontano con le differenti forme che la famiglia può assumere al giorno d’oggi.
Terzo Appuntamento
26 Ottobre dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo saranno due, perché molto brevi: God Save The Queere Ave Mary di Michela Murgia

«Vorrei capire, da femminista, se la fede cristiana sia davvero in contraddizione con il nostro desiderio di un mondo inclusivo e non patriarcale, o se invece non si possa mostrare addirittura un’alleata. Da cristiana confido nel fatto che anche la fede abbia bisogno della prospettiva femminista e queer, perché la rivelazione non sarà compiuta fino a quando a ogni singola persona non sarà offerta la possibilità di sentirsi addosso lo sguardo generativo di Dio mentre dichiara che quello che vede “è cosa buona”».
Si può essere persone femministe e cattoliche nello stesso tempo?
Michela Murgia, cattolica, pensa di sí.
E questo audace pamphlet, popolare e coltissimo, sfida il senso comune, e con lucidità e ironia ci spiega perché.

«Dovevo fare i conti con Maria, anche se questo non è un libro sulla Madonna. È un libro su di me, su mia madre, sulle mie amiche e le loro figlie, sulla mia panettiera, la mia maestra e la mia postina. Su tutte le donne che conosco e riconosco. Dentro ci sono le storie di cui siamo figlie e di cui sono figli anche i nostri uomini: quelli che ci vorrebbero belle e silenti, ma soprattutto gli altri. Questo libro è anche per loro, e l’ho scritto con la consapevolezza che da questa storia falsa non esce nessuno se non ci decidiamo a uscirne insieme.»
La chiesa è ancora oggi, in Italia, il fattore decisivo nella costruzione dell’immagine della donna. Partendo sempre da casi concreti, citando parabole del Vangelo e pubblicità televisive, icone sacre e icone fashion, encicliche e titoli di giornali femminili, questo libro dimostra che la formazione cattolica di base continua a legittimare la gerarchia tra i sessi, anche in ambiti apparentemente distanti dalla matrice religiosa. Anche tra chi credente non è. Con la consapevolezza delle antiche ferite femminili e la competenza della persona di fede, ma senza mai pretendere di dare facili risposte, Michela Murgia riesce nell’impresa di svelare la trama invisibile che ci lega, credenti e non credenti, nella stessa mistificazione dei rapporti tra uomo e donna.
Secondo Appuntamento
14 settembre dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo sarà La donna gelata di Annie Ernaux.
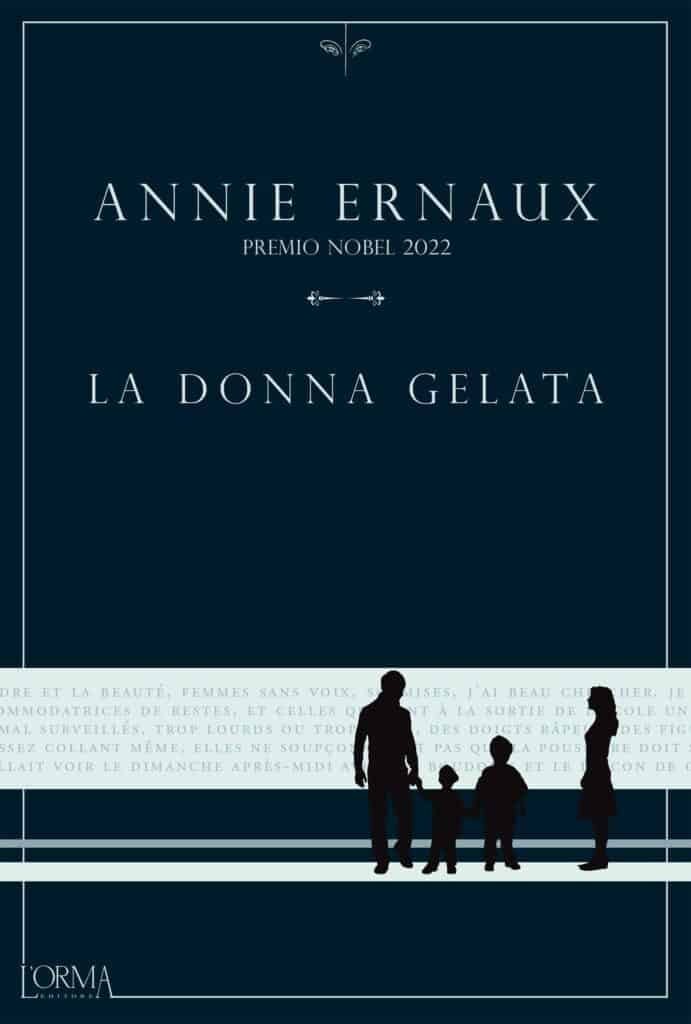
Difficile estrarsi dalle norme imposte dalla società, anche quando si conoscono e si rifiutano. Nonostante un’infanzia libera e ispirata da modelli femminili forti, Annie Ernaux si ritrova inghiottita dalla condizione femminile della propria epoca. A trent’anni è sposata, ha due figli, un marito ed una casa. Ma è una donna gelata. Come tante donne ha sentito lo slancio e la curiosità spegnersi giorno dopo giorno, relegata al ruolo della buona madre e donna di casa, ciò che si ritiene essere la condizione “normale” di una donna.
Annie Ernaux ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2022 “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui svela le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”. La sua scrittura diventa un’arma affilata per sezionare la verità.
Primo Appuntamento
14 giugno dalle ore 18.00
Palazzo del Capitano, Piazza Grande n. 7
Montepulciano
Il libro che leggeremo e di cui parleremo sarà Quaderno Proibito di Alba de Cespedes.

«Ho fatto male a comperare questo quaderno, malissimo. Ma ormai è troppo tardi per rammaricarmene, il danno è fatto»: con queste parole inizia il suo diario Valeria Cossati, la protagonista di questo romanzo, una donna della classe media nell’Italia degli anni Cinquanta. Poco più di quarant’anni, due figli grandi, un marito disattento, un lavoro d’ufficio che svolge senza apparente passione, Valeria è assorbita dal ritmo “naturale” della quotidianità piccolo-borghese, schiacciata, senza quasi rendersene conto, tra i suoi ruoli di moglie, madre, impiegata. Un giorno però, colta da un impulso che a lei stessa appare irragionevole e inspiegabile, acquista un taccuino su cui comincia ad annotare fatti minuti e riflessioni. Nello spazio “proibito” della scrittura, Valeria scopre i conflitti sotterranei che pervadono la sua esistenza, le aspirazioni frustrate, i risentimenti nascosti; dà voce a una vita interiore da anni sopita, esprime una propria individualità, una precisa coscienza rivelata dai gesti e dai pensieri della vita quotidiana.
Dove posso trovare il libro?
In prestito gratuito
Biblioteca Archivio Piero Calamandrei / Montepulciano
oppure in vendita
Libreria Centofiori / Montepulciano
La Terra di Mezzo / Sant’Albino
Vald’O / San Quirico d’Orcia
L’ingresso è libero e non è indispensabile aver letto il libro per partecipare 🙂