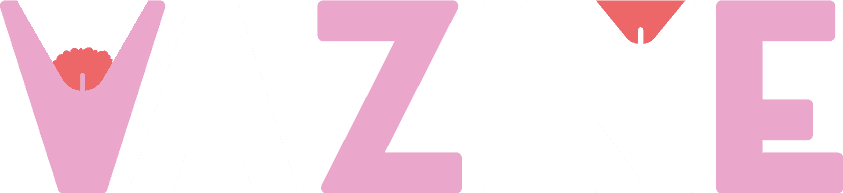VaZine
L’ABORTO: DA REATO A DIRITTO DELLA DONNA
La legge 194/1978.
«1. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto» (art. 546 Codice Penale, Aborto di donna consenziente - abrogato)
Prima del 1978, in Italia l’aborto era un reato disciplinato dal Codice Penale, nel Libro Secondo “Dei delitti in particolare” al Titolo X “Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe”.
In particolare, l’art. 545 c.p. prevedeva la reclusione da sette a dodici anni per chiunque avesse cagionato l’aborto di una donna, senza il consenso di lei.
Il successivo art. 546 c.p. puniva con la reclusione da due a cinque anni sia la persona che provocava l’interruzione di gravidanza, sia la donna incinta che vi acconsentiva. Si applicava, tuttavia, la disposizione dell’art. 545 c.p. se la donna risultava essere minore di anni quattordici, o, comunque, non dotata di capacità d’intendere o di volere oppure se il consenso le era stato estorto con violenza, minaccia, suggestione, ovvero se le era stato carpito con l’inganno.
L’art. 547 c.p., invece, puniva, sempre con la detenzione, questa volta da uno a quattro anni, la donna che si procurava l’aborto in modo autonomo.
L’unica riduzione di pena invocabile in relazione alle suddette fattispecie di reato era costituita dalla «causa di onore» (art. 551), nella circostanza in cui l’interruzione di gravidanza era compiuta per «[…] salvare l’onore proprio o quello di un prossimo congiunto».
L’interruzione volontaria di gravidanza non era solo considerata una pratica illegale di per sé, ma era punita anche la propaganda e l’informazione sui metodi anticoncezionali. L’articolo di riferimento era il 553 c.p., intitolato “Incitamento a pratiche contro la procreazione” e puniva chiunque in pubblico incitasse a pratiche contraccettive e chiunque divulgasse informazioni e conoscenze finalizzate a mettere in luce favorevole tali pratiche.
La rivoluzione culturale e sociale avviatasi in Italia nella seconda metà degli anni Sessanta ha messo in luce l’esigenza di riconoscimento di alcuni fondamentali diritti civili. È dal riverbero di questo movimento, infatti, che in Italia venne approvata la legge sul divorzio, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché la riforma del diritto di famiglia, legge n°151 del 19 maggio 1975, che pose sullo stesso piano marito e moglie all’interno del contesto familiare.
Tra le leggi che rappresentano gli approdi più significativi di questo profondo periodo di cambiamento vi è la legge del 22 maggio 1978, n. 194, rubricata “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Tale legge rispose all’istanza sociale, collettiva di legalizzazione dell’aborto e rappresentò un importante risultato, ottenuto al termine di anni di aspra lotta.
Le stime sull’aborto clandestino furono decisive nel far emergere l’esigenza di garantire l’accesso ad una procedura medica sicura. Occorre considerare che non solo le pratiche clandestine erano alquanto brutali (come, ad esempio, la spremitura dell’addome o l’inserimento di mezzi meccanici nel cavo uterino), ma le conseguenze lesive potevano essere così gravi da comportare la morte della donna.
La trasformazione della disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza iniziò con una storica sentenza della Corte Costituzionale, la n.27, che il 18 Febbraio 1975 sancì l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del codice penale. In particolare, alla base della decisione della Corte vi era la considerazione per cui l’articolo in questione non prevedeva l’ipotesi del c.d. aborto terapeutico, se non in stato di necessità. Questa particolare ipotesi, infatti, poteva ricorrere soltanto quando sussisteva l’inevitabilità e l’attualità del pericolo di un grave danno alla persona. Al contrario, l’aborto praticato a scopo medico per evitare che la donna potesse subire aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche, rimaneva sanzionato penalmente.
Sulla base di queste considerazioni, si ritenne che la condizione della donna gestante non trovasse adeguata tutela nella disciplina vigente.
Il merito della sentenza in commento fu quello di affermare la prevalenza della vita e della salute della donna rispetto al feto, anticipando il rilievo di elementi quali la salute psicologica e le circostanze sociali ed economiche previste dalla L. 194/1978.
Seguendo le orme di questa sentenza, il passo verso l’approvazione della legge 194/1978 fu breve. Nel 1978, fu presentato un testo di legge, che superò velocemente sia il vaglio della Camera che quello del Senato. Il 22 maggio 1978 venne promulgata ed entrava quindi in vigore la legge n.194, a firma del Presidente del Consiglio Andreotti, della ministra Anselmi e dei ministri Bonifacio, Morlino e Pandolfi.
Fu la seconda legge sanitaria di quell’anno, il ’78, che vide approvate tre leggi fondamentali che cambiarono radicalmente la sanità italiana: oltre alla legge sull’aborto, infatti, a maggio dello stesso anno apparve in Gazzetta la legge n.180, che chiudeva i manicomi e rivoluzionava l’assistenza psichiatrica, e a dicembre la legge n. 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, superando il sistema mutualistico e sancendo il diritto universale alla tutela della salute.
Con la 194, il Parlamento giunse alla ratifica della regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza stabilendone le condizioni che tutt’oggi legittimano il suo ricorso.
In base a questa legge, la donna può richiedere di accedere al servizio di IVG entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari, mentre è possibile far ricorso all’aborto nei mesi successivi solo per motivi terapeutici. In particolare, la donna può ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, cioè in un ospedale o in un poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza.
In generale, la legge 194 si propone come una forma di dialogo tra i diritti della donna e l’interesse alla vita del concepito, mantenendo, tuttavia, come fondamento la prevalenza della salute fisica e psicologica della donna.
Secondo quanto prescritto dall’art. 12, la richiesta di IVG dev’essere fatta personalmente e volontariamente dalla donna: durante l’intero percorso deve esserle garantito l’anonimato e il rispetto della sua dignità. Qualora la richiesta di interruzione di gravidanza riguardi una minore, si ritiene necessaria l’autorizzazione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi eserciti su di essa la tutela. A rendere lecito l’intervento prescindendo le autorizzazioni, è solo un accertato stato di imminente pericolo per la vita della minore di qualsiasi età.
Nonostante l’entrata in vigore della legge 194, il dibattito a livello di opinione pubblica non si spense. Dapprima arrivò la condanna ufficiale della Chiesa, poi la proposta di un referendum abrogativo della legge, avvenuto nel 1981. In tale occasione, tuttavia, il 68% degli italiani decideva di non apportare modifiche alla 194 e quindi di mantenerla in vigore così come approvata dal Parlamento il 22 maggio 1978.
Sebbene siano trascorsi decenni dalla sua approvazione, la 194 è una legge che fatica ad esser applicata.
Recentemente, è stata trasmessa al Parlamento la “Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della Legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78)”. Tale documento ha evidenziato forti differenze territoriali tra Regioni quanto ad accesso alla contraccezione, nonché alle strutture sanitarie che effettuano le IVG e al supporto dei professionisti socio-sanitari nei consultori familiari.
All’art. 9, la legge 194 stabilisce che il servizio di interruzione volontaria di gravidanza debba essere presente in tutti gli enti ospedalieri. Al contrario, si registra una forte difficoltà di accesso all’aborto.
In merito alle obiezioni di coscienza da parte di ginecologi, anestesisti e personale non medico, poi, si osserva una maggiore diffusione nel Sud del Paese, dove le percentuali di obiettori sono mediamente più alte rispetto al resto del Paese.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 9, che si occupa in modo specifico dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario, è stabilito che l’obiezione di coscienza non possa essere invocata quando il proprio intervento «è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo» e anche che «l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento».